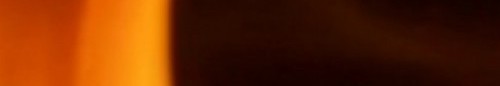I corpi che continuano ad attrarsi, nonostante i limiti a cui parrebbero sottoposti – sopraffazione, solitudine o morte – parlano linguaggi diversi nel romanzo di Lindqvist e nel film di Alfredson. Stando a quanto dichiara nelle note finali e nei ringraziamenti, Lindqvist ha lavorato con una materia sostanzialmente realistica se non autobiografica, vestita con un abito che avrebbe potuto soffocarne la vitalità e che invece, com’era nelle ambizioni dell’autore, ha finito col valorizzarla. Di quest’abito, intessuto della sconfinata e insidiosa materia delle storie di vampiri, Lindqvist ha peraltro puntato ad assumere tutta la pesantezza, inserendo nel romanzo buona parte dei topoi del genere, a partire da quello che dà il titolo all’opera stessa. Alfredson, da parte sua, dimostra di aver compreso perfettamente come, proprio nell’incontro tra la realtà del protagonista bambino e questa tradizione leggendaria, risieda la forza della fabula. Da questa prospettiva, risulta agevole supporre che, non solo per esigenze di trasposizione e per carenze di budget, si sia scelto nella trasposizione cinematografica di limare così profondamente la materia narrativa, al punto da far emergere più nettamente i punti di forza essenziali della storia, suggerendo talvolta un senso diverso e una profondità inedita, grazie soprattutto ad alcune oculate omissioni. Nonostante quest’attenta selezione, il film non si allontana minimamente dall’assetto di base del romanzo. Per quanto doppiamente insidioso, a causa della scarsità dei mezzi a disposizione, il confronto con il genere, ad esempio, non viene mai evitato da Alfredson, che trova, in queste asperità, alcune soluzioni geniali (l’eleganza della regia risplende più volte nei dettagli, in scene in cui accade qualcosa di fondamentale solo in secondo piano e in un angolo dell’inquadratura), mentre altre volte ricade nella banalità (la mano insanguinata di Lacke che spunta dalla porta, l’autocombustione di Virginia), che peraltro neppure gli effetti speciali, davvero inadeguati, possono mascherare, come invece spesso accade negli horror, dove effetti e suspence tentano di distrarre lo spettatore disgustato più del voluto. Alfredson ha in ogni caso troppo rispetto per la storia, il cinema e la sua stessa creatività, per dedicarsi, in questa opera di sfoltimento, a tagli anonimi ed orizzontali. Un visibile sbilanciamento viene operato nel tema della pedofilia, che nel romanzo è anzitutto l’origine di un male non cercato, non voluto, di cui Eli continua ad essere vittima, anche operando a sua volta il male. Da questi presupposti, deriva la sgradevolezza di Håkan, così come la sua natura maligna, che viene pienamente fuori nella sua metamorfosi. Anticipando la conclusione della sua vicenda personale, omettendo del tutto tale metamorfosi e facendo inoltre comparire questo personaggio in atteggiamenti esclusivamente protettivi e comprensivi nei confronti di Eli, Alfredson apre per sfondamento una nuova dimensione di senso. La stessa violazione originaria subita da Eli rimane sullo sfondo, confinata nella fuggevole visione di una cicatrice. Il risultato è una vera e propria rivoluzione. Håkan non appare qui come il pedofilo ripugnante e profittatore, ma come un necessario sostegno per Eli, compito che svolge peraltro con straordinaria dedizione. L’unione finale di Oskar ed Eli appare allo spettatore non soltanto come il lieto fine del romanzo, ma come una scena di profonda malinconia, che contiene nella felicità dei due un’irrimediabile tristezza. Da dove deriva una simile malinconia in un finale che parrebbe superficialmente lieto? Da una semplice idea, non affermata chiaramente nel film, piuttosto lasciata emergere per omissione di tutti quegli elementi capaci di renderla insostenibile in relazione al romanzo: che Oskar, cioè, seguendo Eli, stia diventando il nuovo Håkan. È l’abisso che separa l’immortalità da ciò che è naturale e umano. Eli, che ha “dodici anni da tanto tempo”, manterrà immutata nel tempo, a differenza dei suoi umani accompagnatori, la sua infanzia; non occorre quindi un grande sforzo di immaginazione per ipotizzare che l’incontro con Håkan sia avvenuto molti anni prima, quando entrambi erano ragazzi. Visto il sacrificio a cui l’amore per Eli ha condotto Håkan, non può che esserci malinconia in un finale che pure mantiene quella forza positiva tipica delle favole, sprigionata da un’unione conseguita, nonostante i molteplici ostacoli. Malinconia profondamente umana, perché la coppia sta andando incontro a un ostacolo stavolta insormontabile: lo scorrere del tempo, che segnerà solo uno dei due. È evidente quindi come l’opera di Alfredson, che si mantiene sostanzialmente fedele al romanzo di Lindqvist, raggiunga picchi d’intensità proprio laddove si concede spazi di originalità. Avviene certo nel finale, per precedente sottrazione di elementi narrativi. Ma un’intensità perfino superiore la si ritrova anche nella scena centrale della piscina, che resta più di altre nella memoria dello spettatore. Lasciata da Lindqvist alla deduzione immaginativa del lettore, questa scena rappresenta la grande eccezione nel progetto di labor limae della trasposizione cinematografica, perché colma, con preziosissimo genio cinematografico, un vuoto narrativo del romanzo.