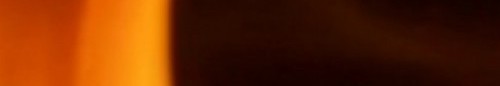A volte, il velo di confortante conformismo si strappava. Accadeva in pochi istanti, per una notizia giunta inattesa: la morte della madre o del marito di una collega. Tutto finiva all’improvviso fuori asse, come a bordo di un mezzo che stesse facendo un gran salto, per l’impatto con un dosso di cui il conducente non si era accorto in tempo. Eravamo nella parabola del volo e trattenevamo il fiato, nella consapevolezza che stare così sospesi era indubbiamente molto peggio dell’atterraggio, per quanto violento, che ci attendeva, perché dovevamo vedercela con la perdita di equilibrio e il terrore di non atterrare mai più o di non atterrare in tempo per riprendere a respirare. Come se quella notizia avesse avuto il potere di azzerare tutto il resto, ognuno evitava gli sguardi altrui e cercava a tentoni il proprio centro, nell’assenza di una mappa che consentisse di ritrovare il consueto equilibrio.
Si restava lì, senza sapere bene come reagire, ingaggiando una personale sfida con le proprie norme comportamentali, alla ricerca di qualche utile riferimento. Una sfida persa in partenza, perché ognuno sapeva far emergere solo il proprio imbarazzo. Su un palcoscenico inutilmente illuminato, si esibivano nervosi gesti di attesa; come in una danza propiziatoria priva di fiducia, provavamo a suscitare un segnale che ci consentisse di tornare a pensare ad altro. Una mano sfogliava nervosamente senza scopo, ripetutamente, le pagine di un libro. Sguardi che così spesso erano stati efficienti messaggeri di richieste e risposte si facevano all’improvviso vacui, lasciandosi sottotitolare da profondi sospiri. Qualche istante ancora e arrivava perfino un imbarazzato colpo di tosse.
Ci si chiedeva a quale strano mondo alludesse quella notizia, quale fosse l’ordine di cose capace di sbaragliare in un attimo le forze apparentemente insuperabili delle convenzioni. Quel tempo sospeso era un territorio di confine, abitato da timidi e smarriti messaggeri di un mondo differente. Avevamo a che fare con una grossa voragine apertasi all’improvviso e, anche se affacciandosi di là si fosse trovato solo il vuoto, valeva davvero la pena di sporgersi, per assistere almeno allo spettacolo delle proprie vertigini.
Eppure, la gente moriva ogni giorno. Solitamente, quando la morte non si avvicinava troppo, si aveva agio di trincerarsi dietro rituali e cerimoniali, contenendola nella formalità del lutto. Quando invece colpiva vicino, troppo vicino, erano proprio le convenzioni, i rituali a fare da appigli, a impedire che il dolore si liquefacesse, invadendo ogni cosa. Ma essere sorpresi così da una simile notizia, proprio in mezzo alle più innocue tra le nostre care abitudini, quelle su cui ogni giorno come abili pattinatori sul ghiaccio scivoliamo senza pensieri, era davvero un fatto inaccettabile, un vile assalto alle spalle, uno scherzo oltremodo scorretto da parte del destino. Bisognava inventare un luogo in cui rinchiudersi in simili occasioni, per raccogliere i pezzi sparsi delle nostre espressioni smagliate e ricomporle in una forma accettabile, che ci consentisse di affrontare efficientemente le incombenze della cerimonia funebre e della raccolta fondi per una corona di fiori.
O forse avremmo dovuto portare proprio lì i nostri alunni, in quella sala insegnanti, davanti all’imbarazzo dei loro docenti, perché sentissero gli scricchiolii di un velo che si squarcia e non potessero scambiare mai più per la sola realtà un sogno così fragile, che sta in piedi soltanto per la nostra sorprendente tenacia, per l’ostinazione con cui ci rifiutiamo di svegliarci.
(nell’immagine: Lucio Fontana, Concetto spaziale. Attesa, 1966-68)