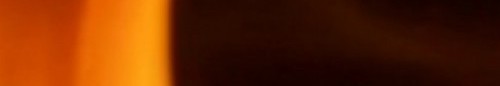Di certo le giornate non aiutavano. Le ore di luce diminuivano lentamente, giorno dopo giorno; senza fretta, perché era chiaro che l’oscurità avrebbe avuto la meglio. Un grigio uniforme legava cielo e terra, in un abbraccio serrato che dichiarava la sua intenzione di non lasciare via d’uscita. Ovunque vedevo manifestazioni dell’immutabile. Mi sembrava che ogni cosa fosse impegnata a mantenere un equilibrio poco rassicurante, con ogni probabilità destinato ad assumere col tempo tinte molto più fosche, ma generalmente considerato – chissà perché, poi – il massimo che ci si potesse permettere.
Io me ne andavo al lago, dopo le ore di lavoro del mattino, mi sedevo su una panchina e guardavo la superficie grigiastra dell’acqua, che non aveva colpa se non quella di ribadire il discorso senza speranza del cielo.
Poteva capitare che mi passasse davanti un cigno, nuotando placidamente. In quella foschia che non riusciva a diventare nebbia, i suoi occhi mascherati di nero mi sembravano del tutto ciechi. Il suo ipotetico sguardo si posava su di me come su un punto vuoto. Se il cigno non fosse stato cieco, o sovrappensiero, avrei dovuto concludere che ero io ad essere diventato invisibile, magari finendo col mimetizzarmi in quel grigio uniforme.
Poi metteva sott’acqua la testa, in cerca di alghe di cui cibarsi, come in un tentativo di suicidio deliberato da tempo, ma con quasi nulle possibilità di andare a buon fine.
Riemergeva, infatti, e quel contrasto tra desiderio e impotenza aveva il potere di commuovermi. Il cigno invece semplicemente riemergeva, senza visibili segni di delusione e senza dare a vedere se in lui prevalesse più la noia o la disperazione. Poi, si reimmergeva. Continuavo a fissare il suo culo proteso verso il cielo e cercavo di immaginare quanto l’acqua nascondeva: il suo lungo collo proteso nella sua massima estensione, il suo becco ansioso di strappare alghe a quel lago.
Mi capitava in quei giorni di andare in libreria a leggere Al culmine della disperazione di Cioran. Avevo cominciato a leggerlo per curiosità e ne ero rimasto catturato senza accorgermene. Non fu perciò una scelta consapevole quella di non acquistarlo; mi era venuto spontaneo fare quella sorta di pellegrinaggio quotidiano, come se sullo scaffale di quella libreria non ci fosse semplicemente un libro, ma una specie di amico difficile da immaginare, a cui sarebbe stato possibile confidare tutto, a cominciare proprio da ciò di cui non avevo piena consapevolezza, ma che c’era: lo sapevo perché premeva, spesso, inutilmente, per venir fuori.
Il dolore alle volte pretende di essere incomunicabile. Tentare di esprimerlo è come cercare con una punta poco affilata di bucare una superficie gommosa. Si osservano i propri tentativi e si attende. Alle volte, sembra perfino di veder fuoriuscire qualcosa; compare su quella superficie, chissà come, una minuscola goccia, alla quale, per quanto si insista e per quanto si attenda, non segue nient’altro. Così, si è costretti a concludere, davanti a quella superficie perfettamente intatta, che fosse solo una goccia proveniente dall’esterno, precipitata lì da chissà dove, chissà come.
Mi sembrava in qualche modo di sconfiggere per un attimo l’incomunicabilità, leggendo. Me ne stavo in piedi, davanti allo scaffale, fingendo di sfogliare quel libro, ma in realtà leggendolo avidamente, come quando si sa che si ha poco tempo a disposizione. In quelle frasi inusuali che non contemplavano la possibilità di minimizzare alcun aspetto della disperazione, che non ne relativizzavano la portata incendiaria, che non miravano ad esorcizzare ma ad infiammare, in quelle parole che mettevano al centro proprio l’ingombrante e inelegante disperazione, io sentivo la superficie gommosa del mio dolore tendersi sempre di più, fino a trasudare, attraverso le fessure improvvisamente aperte da quell’estremo stiramento, una materia liquida che avrei potuto bere senza pretendere che mi dissetasse e di cui avrei potuto dire con estrema certezza: «è mio».