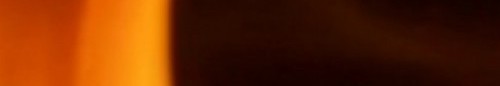E se i mostri fossero tutto quello che c’è da salvare?
Come si può pretendere di osservare oggettivamente un essere umano? Non è l’io che è esploso in personalità multiple, è il proprietario delle supposte personalità multiple a non saper più vedere i ponti con cui comunicano. Sempre cala questo velo tra noi e le cose; più pesante ancora è il velo tra noi e gli altri. E il più opaco dei veli ci divide da noi stessi. L’impressione è che ogni volta si vada a interrogare la Sfinge, con la pretesa di risolvere l’enigma, solo prendendone alla lettera le parole. Ci mancano gli strumenti per cogliere più di quello che emerge. E un sottile senso di inadeguatezza ci comunica che ciò che per i nostri strumenti non emerge – e quindi non esiste – è la gran parte di quello che dovremmo osservare e conoscere.
Che posto ha l’amore, che ruolo i suoi mostri, in questo che, pur senza mostri e senza amore, ha già la perfetta parvenza di un intrico? Un posto cruciale, come la sofferenza. Solo amore e sofferenza possono smuovere a tal punto le cose, da fare eccezionalmente emergere quel che è sommerso e invisibile. Sarebbe solo un’assurda pretesa attendersi che tutto questo emerga in circostanze normali. Siamo come dei laghi, in cui l’acqua si fa più densa man mano che si va più in profondità e ad ogni metro un po’ meno si vede e tutto sembra meno puro, proprio perché brulicante di vita.
Oh oh, che cosa ci sarà là sotto? Mostri.
Tutto ciò che avviene nel lago della nostra esistenza va a prendersi il suo posto, possiamo solo illuderci di dimenticare o ignorare fatti, ferite, persone. E le cose che hanno un peso più rilevante vanno in genere a depositarsi là sul fondo, a meno che non siamo noi a costruire per loro imbarcazioni adeguate, stratagemmi più o meno geniali, più o meno efficaci per tenerle a galla. Purtroppo il più delle volte non si ha il tempo di farlo o si è troppo impegnati a guardare l’affondamento per attivarsi. Altre volte ci si prova ma si fallisce, assistendo altrettanto impotenti all’affondamento dei rimedi stessi. Non resta perciò che provare a farsi palombaro e, tra un’immersione e l’altra, osservare i ragni.
In Aion, Jung definisce il ragno come un messaggero del più profondo e indomabile inconscio sociale. Nel tarantismo salentino, ciò che impressiona maggiormente è la contraddizione, forse solo apparente, nella quale si sviluppa il ballo rituale e curativo. I testimoni dei tempi in cui il tarantismo era un fenomeno davvero vivo mostrano, nelle loro dichiarazioni, di saper collegare benissimo i malesseri delle tarantate alle loro probabili cause psicologiche, eppure ciò nonostante non rinunciano a credere né che un ragno le avrebbe morse, né al potere curativo dei balli, solo antidoto al veleno che la taranta avrebbe instillato nel loro sangue.
Nell’ultimo cavaliere di King, a un certo punto, il protagonista scoperchia una cantina sotterranea. Lascia che la luce filtri. Laggiù è pieno di ragni giganti e immondi. La luce, penetrando là dentro, pensa il pistolero, avrebbe avuto il potere di dissolverli. Tuttavia, non si tratta di lottare contro i mostri, ma piuttosto di farsi alleati del loro desiderio di emersione, cercando un modo per farli venire alla luce, senza che ne restino distrutti.