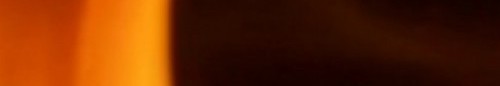Il mattino dell’11 giugno 1963, nel cuore di Saigon, il monaco buddhista Thích Quảng Đức si sedette nella posizione del loto in mezzo a una strada. La città si muoveva come un animale distratto, ignara di ciò che stava per accadere. Lui rimase immobile, assorto in una preghiera che sembrava trapassare i muri, i veicoli, le coscienze. Si fece cospargere di benzina e si diede fuoco. Il suo corpo ardeva come se avesse deciso di trasformarsi in pura luce. Nessun urlo, nessun gesto di fuga: solo una compostezza che sfidava l’immaginazione umana. Quel gesto estremo fu un grido muto contro la persecuzione che il regime sudvietnamita di Ngô Đình Diệm stava infliggendo ai buddhisti. Un atto di resistenza spirituale, tanto radicale da sembrare impossibile.
Più del racconto dei testimoni, fu un’immagine a scuotere il mondo. Malcolm Browne, fotografo dell’Associated Press, era lì per una combinazione di perseveranza e intuizione. Il suo scatto iconico mostrò il corpo in fiamme di Thích Quảng Đức, i monaci che lo avevano assistito nell’immolazione, la folla incredula intorno e soprattutto quell’immobilità che aveva qualcosa di sovrannaturale. La fotografia fece il giro del pianeta, come un meteorite che trascina con sé un frammento di verità. Non era solo un documento, era un monito: una ferita aperta nella coscienza dell’Occidente, una domanda che nessuna diplomazia poteva anestetizzare, il volto della protesta estrema di chi non dispone più delle parole, e allora brucia.
Sei anni dopo, a Praga, un altro giovane sentì l’eco di quel gesto lontano. Jan Palach, uno studente, camminò fino a piazza San Venceslao il 16 gennaio 1969 e si diede fuoco per protestare contro la repressione sovietica e l’inerzia quasi ipnotica della società cecoslovacca dopo la fine della Primavera di Praga. Palach conosceva la storia dei bonzi vietnamiti, aveva visto la foto di Browne, aveva letto dei corpi ardenti come ultimo tentativo di risvegliare gli altri. In quell’immagine aveva intravisto un linguaggio universale del dolore, una grammatica estrema della resistenza: quando tutte le porte si chiudono, resta il corpo come ultima voce.
Il fuoco come linguaggio. Non della distruzione cieca, ma della coscienza. Una lingua che non vuole annientare ciò che tocca, bensì destarlo. È una lingua pericolosa, perché attrae e insieme spaventa, come ogni verità che non lascia scampo.
Antonio Moresco ha trasformato ne Gli incendiati questo linguaggio estremo in visione. Nel suo romanzo, il fuoco non è solo protesta o martirio: è un richiamo misterioso che attraversa due personaggi, li costringe a un viaggio dove la combustione diventa metamorfosi. I corpi che bruciano nel libro di Moresco sembrano richiamare quei gesti storici, trasfigurandoli. Il fuoco diventa un varco, un passaggio in cui la realtà si assottiglia e rivela ciò che di solito resta sepolto. Anche lì, bruciare significa comunicare, abitare un’altra frequenza del reale, dire l’indicibile con l’unico mezzo che non può essere censurato. Alcuni anni più tardi, Moresco pubblicherà Gli increati e lì “l’uomo torcia” Jan Palach comparirà come personaggio.
Il filo che lega Saigon, Praga e la visione incandescente di Moresco è un paradosso: il fuoco come ultima possibilità di parola. Un linguaggio che non vuole convincere, ma scuotere; che non vuole distruggere, ma trasformare; che non salva nessuno, ma non permette più di dormire. Il fuoco, insomma, come una voce che nessun potere può zittire: una voce che continua a parlarci, nonostante tutto, forse proprio perché non ha mai smesso di bruciare.