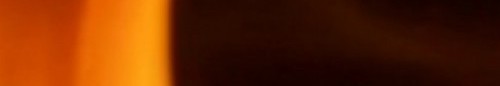In quel tempo, si separavano le cose con metodica precisione ed era necessario un sovrumano sforzo d’immaginazione per pensare qualcosa che non fosse già stato catalogato. L’immaginazione, del resto, appariva come uno sterile retaggio di tempi lontani. Molti tuttavia restavano convinti di essere ben dotati di capacità immaginative e di esercitarle poco meno che quotidianamente. Quello che facevano era in realtà combinare stancamente e in modo inevitabilmente prevedibile immagini già presenti nell’etere, di cui si era abusato così a lungo da renderle innocue e mute. Ciononostante continuavano, quelle immagini, a parlarci meccanicamente, tramite il loro stesso ricordo ben fissato in noi dalla ripetizione. Sentivamo che un sordo automatismo le identificava istantaneamente con un ricordo lontano e ci proiettava beffardamente in un punto dello spaziotempo che credevamo dimenticato, mentre eravamo convinti di abitare ancora il presente.
Ad onor del clima, va detto che a volte arrivava il vento e ne approfittavamo per respirare a pieni polmoni, sedotti dall’idea che tutto potesse cambiare, arresi all’ansia, davanti a un fenomeno così insolito che avrebbe potuto durare molto poco e chissà quando ripetersi. Perché si aprivano, in quelle occasioni, spazi di cui non avremmo potuto ipotizzare l’esistenza. Era il vento a spalancarli e noi, che non avevamo il controllo neppure del nostro respiro, potevamo appena osservarne gli effetti e provare a reimparare passo dopo passo il segreto del movimento.
Erano le cose di sempre quelle che adesso tutte spettinate mettevano in discussione i loro contorni, prima così inequivocabili e netti? Tutto stava cambiando, restando uguale? Ogni cosa si riposizionava? O piuttosto si riconfigurava? Ricordo che più volte in simili occasioni trovai perfino il coraggio di ipotizzare che le cose non esistessero in quanto tali, che i loro confini non fossero che trucchi di semplificazione della nostra abborracciata percezione.
In genere, il vento non arrivava a sera e, dietro il vetro, troppo presto ogni cosa si placava, accettando il riposo, mentre tu sospiravi. “Non lo sopporto”, dicevi riferendoti al vetro, consapevole che non aveva più senso oltrepassarlo. Immersi in quella stasi, temevamo di soffocare. Respiravamo senza saperlo. Le ombre rafforzavano i contorni delle cose, che, se respiravano, non lo davano a vedere. Un gatto, tra tutte le creature dagli umani la più invidiata, sbadigliava intanto, preparandosi ad una notte di avventure.
(nell’immagine: Giovanni Fattori, La libecciata, 1880-85)